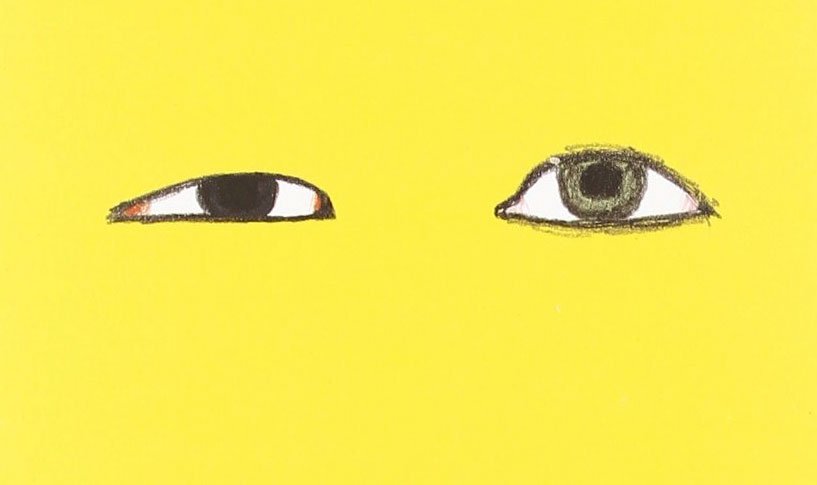Il Giappone di Amélie Nothomb: “Stupore e tremori”
“Stupore e Tremori”, libro di Amélie Nothomb pubblicato nel 1999, è un atto di accusa contro alcuni aspetti della cultura giapponese, ma anche un gesto d’amore verso i giapponesi
Il signor Haneda era il capo del signor Omochi, che era il capo del signor Saito, che era il capo della signorina Mori, che era il mio capo. E io, non ero il capo di nessuno. Si potrebbe dire diversamente. Io ero agli ordini della signorina Mori, che era agli ordini del signor Saito, e così di seguito, con la precisazione che gli ordini verso il basso potevano saltare i gradini della scala gerarchica. Per cui, alla Yumimoto, io ero agli ordini di tutti.
da “Stupore e tremori”
Comincia così Stupore e Tremori, libro di Amélie Nothomb pubblicato nel 1999, con una catena gerarchica che nel romanzo ricoprirà un ruolo fondamentale. Nel contesto di questa struttura sociale prestata all’ambito lavorativo si sviluppano infatti le vicende autobiografiche della stessa Nothomb, belga con un’ottima conoscenza della lingua giapponese assunta dalla multinazionale Yumimoto in veste di traduttrice/mediatrice. A prima vista un compito facile, in realtà una lenta discesa in un dedalo di rapporti interpersonali sempre più incomprensibili e opprimenti figlio di approcci culturali agli antipodi ma anche risultato di irrimediabili malintesi. Un rapporto causa-effetto che porterà Nothomb a un demansionamento inarrestabile fino allo scalino più basso dell’ordine sociale della Yumimoto, in una narrazione kafkiana e a suo modo inquietante resa “accettabile” soltanto dall’ironia con cui viene raccontata.
Anche perché quella che sembra la semplice cronaca di una vicenda personale quantomeno surreale agli occhi di un occidentale, nasconde in realtà una riflessione profonda in cui i piani di lettura si intersecano e si integrano vicendevolmente. Certo, c’è il clash culturale tra modello comportamentale europeo e giapponese a tirare le fila principali della trama, con il secondo chiamato a trasformare gli ordini in imperativi categorici, il rispetto per il proprio superiore in una sudditanza fisica e psicologica, l’essere inadatti a un compito in un motivo di disonore e la punizione in sopruso. Ma c’è anche molto altro.
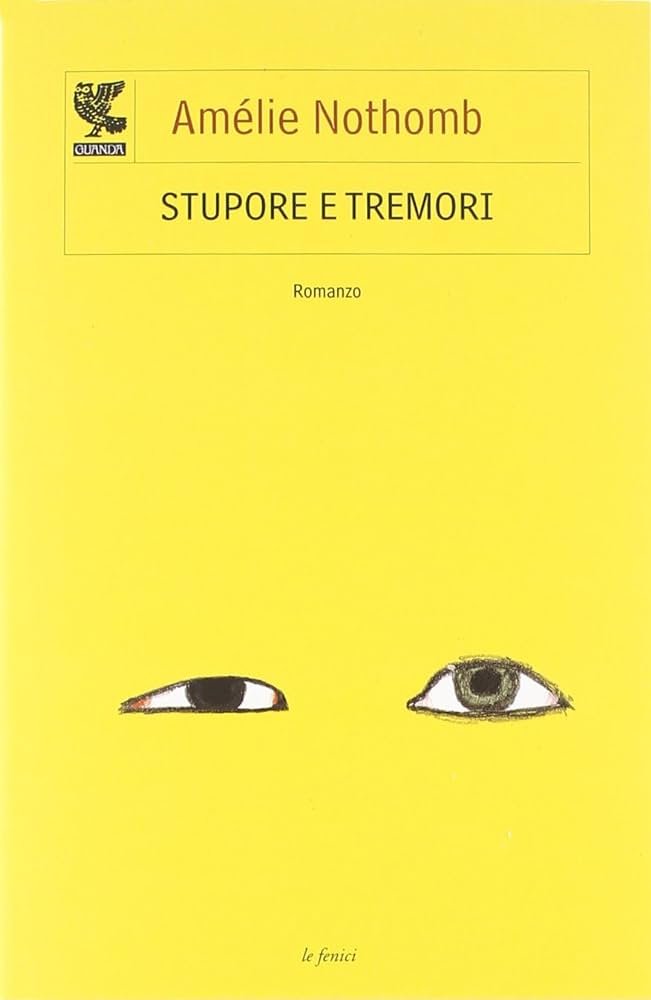
Uno degli spunti più interessanti del libro sono sicuramente le dinamiche che ruotano attorno al rapporto tra la protagonista e il suo diretto superiore, ovvero l’«agile e graziosa da morire» Fubuki Mori. Inizialmente Nothomb è una donna europea calata in una cultura fortemente maschilista e discriminatoria: il fatto che lei sia occidentale e che conosca così bene la lingua giapponese diventa a un certo punto un motivo di vergogna, tanto che le viene ordinato esplicitamente di non capirla più («c’è sempre modo di ubbidire a un ordine – le dice il signor Saito – e i cervelli occidentali dovrebbero capirlo una buona volta»). Per questo la bellezza e l’iniziale gentilezza di Mori vengono idealizzate da una protagonista che in lei vede un modello di donna atipico per le latitudini in cui si trova, simbolo di emancipazione, intelligenza e grande eleganza. Finché l’ennesimo equivoco tra le due non trasforma il sogno in un incubo e la giapponese nel vero aguzzino di Nothomb, insensibile fino all’inverosimile e capace di sottoporla a un mobbing spietato.
Eppure Fubuki Mori, con tutti i suoi difetti, non è altro che una vittima della società in cui vive ed è cresciuta, e Nothomb ne è consapevole. Tanto che in un fondamentale passaggio del libro si legge: «Se bisogna ammirare la [donna, ndr] Giapponese (e bisogna farlo), è perché non si suicida. La cospirazione contro il suo ideale comincia in tenerissima età. Le ingessano il cervello: “se a venticinque anni non sei ancora sposata, hai di che vergognarti”, “se ridi, non sei fine”, “se il tuo viso esprime un sentimento, sei volgare”, se menzioni l’esistenza di un pelo sul tuo corpo, sei immonda”, “se un ragazzo ti bacia sulla guancia in pubblico, sei una puttana”, “se mangi con piacere, sei una scrofa”, “se provi piacere a dormire, sei una vacca”. Precetti del genere sarebbero ridicoli, se non ti si conficcassero dentro. Perché in fin dei conti, ciò che si trasmette alla Giapponese attraverso questi dogmi insensati è che non bisogna sperare in niente di bello. Non sperare di godere, perché il piacere ti annienterà. Non sperare di innamorarti, perché non vali abbastanza: quelli che ti ameranno lo faranno per i tuoi miraggi, mai per la tua verità. Non sperare che la vita ti porti qualcosa, perché ogni anno che passa ti leverà qualcosa. Non sperare in una cosa semplice come la tranquillità, perché non hai nessuna ragione per startene in pace. Spera di lavorare. Visto il tuo sesso, avrai poche possibilità di arrivare in alto, ma spera di servire la tua azienda. Lavorare ti farà guadagnare dei soldi da cui non trarrai nessuna gioia, ma da cui potrai eventualmente trarre dei vantaggi, per esempio in caso di matrimonio – perché non sarai tanto stupida da supporre che qualcuno possa volerti per il tuo valore intrinseco. A parte questo, puoi sperare di vivere a lungo, cosa che in sé non ha nulla di interessante, e di non conoscere il disonore, cosa che invece ha un fine in sé. Qui si ferma la lista delle tue speranze lecite».
Stupore e Tremori è un atto di accusa contro alcuni aspetti della cultura giapponese, come ad esempio la visione della vita esclusivamente in rapporto alla funzione (lavorativa e non) che si ricopre, ma anche un gesto d’amore verso i giapponesi e la loro capacità di resilienza in un sistema sociale in cui il gruppo è più importante del singolo e l’individuo è inchiodato a dinamiche sociali quotidiane che lasciano ben poca libertà personale. A confermarcelo non sono solo i piccoli spiragli di speranza che si scorgono durante la narrazione – su tutti, la comprensione e l’affetto dimostrati (e immediatamente repressi) dal dirigente Tenshi nei confronti della protagonista – ma soprattutto una conclusione in cui alcuni dei personaggi rivelano la loro vera natura, dimostrandosi implicitamente vittime di un sistema che non prevede facili vie di fuga.
Il passo successivo alla lettura di questo splendido romanzo di Amélie Nothomb potrebbe essere la visione dell’altrettanto splendido – e per certi versi complementare – Perfect Days di Wim Wenders.